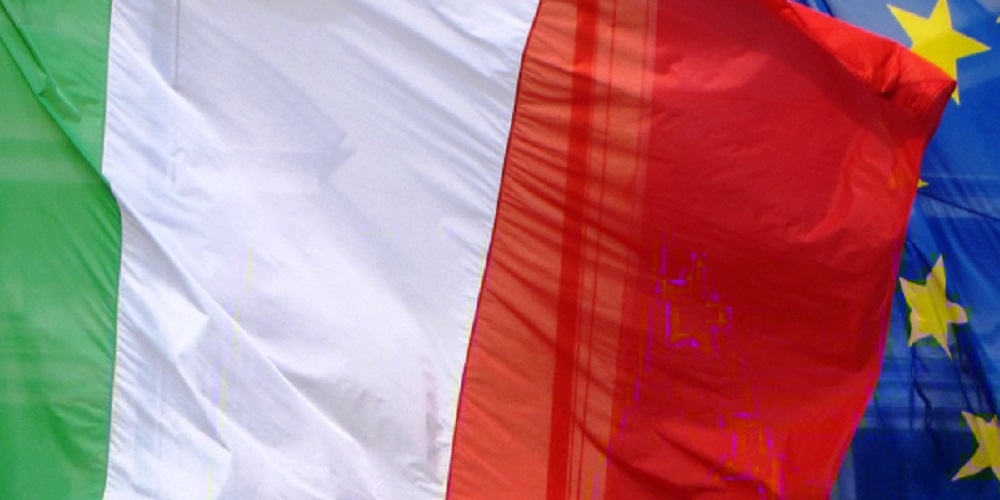Facciamo due conti. Se si sommano i neoeletti al Parlamento Europeo che non appartengono ad alcun gruppo politico, o ad alcun gruppo politico del Parlamento uscente, si arriva alla non modica quantità di 101 parlamentari.
101 su 751: una forza parlamentare di tutto rispetto. Che cerca casa. Che non si riconosce nelle famiglie politiche tradizionali e che mantiene diffidenza e una certa qual estraneità alle liturgie di Bruxelles.
I due principali raggruppamenti politici, quello dei popolari e quello dei socialisti, quest’ultimo ridenominato “Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo, un nome che neanche Lina Wertmüller avrebbe potuto pensare, sommati insieme contano in tutto 405 rappresentanti, poco più della metà. Sono sufficienti questi pochi numeri per capire il significato del voto dello scorso 25 maggio. Noi siamo abituati a leggerlo in chiave nazionale, anche perché tutta la campagna elettorale si svolge – e anche questa volta si è svolta – con argomenti che poco hanno a che fare con le politiche europee.
Al dato nazionale occorrerà dunque dedicare tre brevi considerazioni finali. Eppure il dato più significativo emerge con chiarezza solo se si guarda al contesto generale. E quel dato mostra con evidenza una cosa: che la fiducia nel progetto europeo è oggi parecchio incrinata. Che i partiti maggiori non sono più tanto maggiori. C’entra la crisi, naturalmente, e una disciplina di rigore finanziario che deprime i consumi, frena gli investimenti, restringe gli spazi del credito bancario alle imprese e alle famiglie.
Ma c’entra anche il cono d’ombra in cui sembra precipitata l’intera architettura europea. Basti pensare che in queste elezioni era per la prima volta in gioco la Presidenza della Commissione: con un’analogia purtroppo molto approssimativa, si tratta pur sempre del Primo Ministro dell’Unione. I socialisti hanno candidato il tedesco Martin Schultz, i popolari hanno candidato il lussemburghese Jean-Paul Juncker. Ma quanti elettori europei hanno sentito di contribuire a questa scelta? E quanti hanno voluto considerarla decisiva? Il risultato, peraltro, costringe molto probabilmente i due principali schieramenti a tentare un accordo e, soprattutto, affida l’intesa a un processo lungo e complesso e a trattative fra governi che si concluderanno solo in autunno, rendendo così molto labile agli occhi dell’opinione pubblica il rapporto tra la figura del Presidente e l’esito del voto di maggio. Se dunque le forze politiche euroscettiche hanno ottenuto un successo significativo, non è per caso o per una congiuntura sfavorevole ma per un limite strutturale dell’europeismo istituzionale. Quello che ci ha portato sin qui, e che non riesce a portarci oltre. Oltre Maastricht, oltre un concerto di regole che sembra pensato per conservare l’esistente, e incapace di indicare una prospettiva. La prospettiva è infatti l’Europa politica. Ma al momento si tratta di un’esigenza vaga, più che di un programma realistico. E soprattutto di un’esigenza che sembra ritagliata su misura per alcuni, non per tutti.
Il nodo della moneta unica e le politiche di austerity che lo hanno stretto attorno al collo delle economie periferiche, è infatti ben lungi dall’essere allentato. Prende così forma una contrapposizione esiziale: da una parte i partiti europeisti tradizionali, che difendono l’Europa come spazio inclusivo di diritti e di libertà, dall’altra un brusco richiamo alla volontà calpestata dei popoli e alla difesa esclusiva degli interessi nazionali. La pace e i commerci rischierebbero un’altra volta di urtarsi contro muri di incomprensione, eretti per difendere comunità nazionali un’altra volta ripiegate su sé stesse.
L’Europa – prima la Comunità, poi l’Unione – è stata costruita politicamente proprio per evitare questo rischio. Ma ora il rischio si ripresenta: con le formazioni apertamente reazionarie che hanno ottenuto risultati sorprendenti in Austria e Danimarca; con il clamoroso successo del Front National diMarine Le Pen, divenuto in Francia il primo partito; con l’altrettanto clamorosa affermazione, in Gran Bretagna, del partito indipendentista di Nigel Farage, quello con cui Grillo pare voglia stringere un’alleanza, nonostante (o forse proprio per) la forte vena di intolleranza xenofoba che lo percorre. E anche in Spagna e Grecia, dove si sono imposte formazioni politiche nuove, ancorate a sinistra (Podemos, figlia della protesta degli indignados, e la lista di Alexis Tsipras) si tratta di forze apertamente critiche nei confronti dell’establishment europeo, con qualche tratto populista e una forte carica di critica sociale. Un’ Europa così non può andare da nessuna parte: i nazionalismi e i populismi euroscettici mettono in pericolo i progressi compiuti nei decenni scorsi, ma coloro che si sentono eredi della migliore civiltà europea non possono più pensare di costruire un’Europa per i popoli e tuttavia senza i popoli, anzi quasi a loro dispetto. Non possono cioè immaginare le migliori e più avanzate disposizioni per il godimento di beni e diritti fondamentali, e riservarle però a pochi, restringendo sempre di più il cerchio di coloro che, di fatto, ne possono fruire. Senza una robusta iniezione di democrazia, insomma, e soprattutto senza un nuovo investimento di senso nel progetto europeo, non basterà votare qualche piccolo aggiustamento al prossimo Consiglio Europeo per ridare slancio all’Unione. È bene che Renzi lo sappia. L’Italia si appresta, infatti, a tenere la guida nel prossimo semestre europeo. E il risultato del Pd rappresenta la più vistosa eccezione al quadro finora descritto. È la prima delle tre considerazioni finali che il voto italiano merita: su quella eccezione bisognerà fare leva.
Seconda considerazione: Renzi ha vinto per tre motivi. Da tenere tutti e tre presenti. Ha vinto perché non è apparso in alcun modo compromesso con la grigia e tecnocratica Europa, da noi ben rappresentata da Monti (il voto dello zero virgola di «Scelta europea» è la più eloquente illustrazione di quale Europa gli italiani vogliano). Ha vinto poi perché ha saputo interpretare una pressante richiesta di cambiamento. E ha vinto perché non è apparso subalterno a nessun potere costituito: non in Italia e neppure fuori dall’Italia. La scontentezza che negli altri grandi paesi europei ha penalizzato le famiglie politiche tradizionali – ad eccezione della Germania, dove la Merkel incassa il dividendo della posizione che in Europa ha saputo assicurare al suo Paese, e dove anche l’SPd recupera proprio grazie alla scelta di andare al governo con la Cancelliera – ha così premiato il Pd, oltre ogni aspettativa. E ha ridimensionato le altre forze politiche. Il centrodestra si è ridimensionato da solo, essendosi presentato diviso, incapace di progettare un dopo Berlusconi e incapace pure di un posizionamento politico chiaro rispetto al governo e rispetto alle prossime scelte a Bruxelles. Grillo invece è stato indubbiamente ridimensionato dalla fiducia accordata dagli italiani a Renzi. Impossibile dire se la parabola discendente del Movimento continuerà anche alle politiche. E questa è la terza e ultima considerazione: le previsioni sono difficili, ma un fatto è certo, il voto alle Europee non si riproduce tale e quale alle politiche, per quanto lo si sia caricato di un significato nazionale. Meglio, al riguardo, non nutrire facili illusioni.