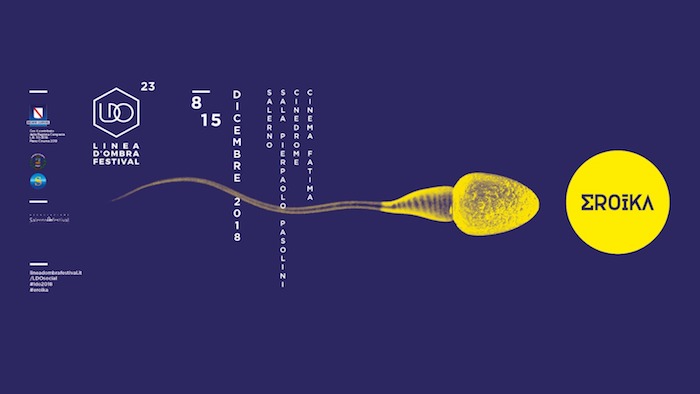Faith, fede. Si chiamava così la piccola di quasi sette mesi deceduta appena sei giorni fa nel carcere di Rebibbia, Roma. Suo fratello Divine, invece, che di anni non ne aveva nemmeno due, è morto in ospedale qualche ora dopo, la sera di San Gennaro. Solo, come il criminale che non era. Che non era lui e che non era nemmeno sua sorella. Li chiamavano bambini detenuti: l’illegalità, violenta e prepotente, li aveva travolti ancora infanti e inconsapevoli. Dietro le sbarre, infatti, vi erano finiti perché ci avevano messo mamma Alice, una giovane tedesca di origini georgiane arrestata lo scorso agosto per possesso di droga e traffico illecito di sostanze stupefacenti. La stessa che il 18 settembre li ha lanciati dalle scale dell’istituto penitenziario nel quale erano rinchiusi insieme. Voleva liberarli, a chi l’ha interrogata in queste ore ha risposto così: Alice desiderava che i suoi figli fossero liberi. In vita, in fondo, non avevano potuto esserlo, costretti com’erano stati all’ombra ingombrante di un peccato mai commesso. Lacrime e rabbia, una storia tragica la loro, tanto triste quanto cruda, surreale e vera. Una vicenda che, tuttavia, è soltanto l’ultimo racconto di un mondo che ignoriamo ma che vive a pochi, pochissimi passi da noi.
Di quel che succede al di là delle mura di cinta delle case circondariali non si interroga mai nessuno, se non una manciata di scrupolosi addetti ai lavori. Eppure, ignorate le manette e oltrepassate le recinzioni, dietro quelle pareti, tra una brandina, un’ora d’aria, qualche divisa e una serie di sbarre a inibire persino l’ossigenazione, ci sono tanti, troppi vissuti personali, un’infinità di sbagli fatti per scelta o per mancanza di alternativa, vite cambiate, esistenze spesso spezzate. Uomini, donne, ragazzi, aguzzini, assassini, disperati, addirittura innocenti. Come i bambini. A tal proposito, i sogni infranti di Faith e Divine ci ricordano che talvolta in carcere ci finiscono persino i più piccoli, figli di detenute costretti a scontare anch’essi la pena delle loro mamme. In Italia, ad esempio, stando ai più recenti dati resi noti dal Ministero della Giustizia (risalenti allo scorso 31 agosto), le madri recluse sono circa 52 – di cui 27 italiane e 25 straniere – per un totale di 62 pargoletti al seguito(rispettivamente 33 le prime e 29 le seconde). Infanti obbligati a crescere in un contesto a loro totalmente inadatto e incurante di quelle tutele fondamentali che sia la Costituzione italiana sia la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo definiscono preminenti pur non essendolo concretamente.
Dagli anni Settanta a oggi, nello Stivale, sono stati cinque i provvedimenti legislativi che hanno posto l’attenzione su questo dramma assolutamente da non sottovalutare: dalla legge 354 del 1975 alla n.62 del 2011, però, nei fatti, è cambiato davvero ben poco. Promesse, ministri della Giustizia uscenti o freschi di elezione, vecchi e nuovi arresti. Checché se ne dica, i più piccoli restano privi di ogni forma di libertà a favore di una maternità che, tuttavia, si fa malata. Forzati ai ritmi del carcere, infatti, i bambini sviluppano nei confronti della genitrice un sentimento eccezionale, ai limiti del sano, spesso ben oltre questo. La mamma è tutto: casa, famiglia, punto di riferimento, amica, ma più il piccolo cresce, più a mancare, tra le parti, è un vero rapporto – che non sia simbiotico – di condivisione e di esperienza, di conoscenza del mondo reale, lì dove non ci sono chiavistelli, sbarre, divise, ed entrambi sono liberi di tenersi per mano alla luce del sole, magari al parco giochi. Al tempo stesso, anche quello della donna verso il figlio diventa un amore sproporzionato, con l’infante che rappresenta l’unico legame possibile con una vita normale, forse la sola ragione per superare i giorni al fresco o la più grande condanna da attribuire alla propria persona.
A risultare ancora una volta schiacciata, quindi, è la dignità che ai grandi come ai piccoli, in cella, è negata ripetutamente, trasformandola in una parola che si svuota ben presto di ogni suo significato, sconosciuta e calpestata nonostante l’interrogarsi del legislatore. Come spesso succede quando si tratta di diritti, infatti, la giurisprudenza ha pensato a una soluzione, la cui applicazione, però, risulta quasi nulla o tardiva. Stando alle normative più recenti, per le donne che hanno dei bambini di cui occuparsi nonostante l’arresto – soprattutto in mancanza di alternative e su base volontaria –, dovrebbero essere previste delle misure di detenzione diverse dalle tradizionali e in ambienti con un ruolo di comunità. Ambienti come gli Istituti a Custodia Attenuata per Madri detenute (ICAM), che sono concepiti, almeno su carta, per creare un’atmosfera di casa normale, più simili a un asilo che a una prigione, in modo da evitare ai minori i traumi della detenzione. Al loro interno, gli agenti di polizia non indossano divise, non vi sono sbarre visibili, gli educatori affiancano le recluse e portano i bambini fuori dalle strutture almeno una volta alla settimana. Su richiesta, li accompagnano anche all’asilo. Per le mamme, invece, le regole sono le stesse del carcere, sebbene le giornate siano dedicate anche alla cura degli ambienti comuni, alla cucina, magari a corsi di pittura o di sartoria. Attualmente, in Italia, ci sono circa 5 strutture di questo tipo dislocate tra Milano (apripista nel 2007), Torino, Venezia, Lauro (in provincia di Avellino) e Cagliari.
Inizialmente, tali istituti erano pensati per far sì che i figli potessero convivere con la genitrice fino ai 3 anni. Dal 2011, però, l’età si è alzata ai 6. Nello stesso periodo, inoltre, è stata prevista l’introduzione delle case famiglia protette, ossia la cosiddetta detenzione domiciliare per le donne condannate a un periodo di reclusione non superiore ai 4 anni (anche se costituente parte residua di maggior pena) con prole al massimo decenne. Tuttavia, a oggi, a disposizione di pochissime mamme, soltanto due di queste case famiglia sono in funzionamento – a Roma e Milano –, soprattutto per motivi economici. La legge, infatti, non prevede copertura finanziaria ma rimanda agli enti locali, il più delle volte senza la disponibilità di un solo centesimo. Ecco che, allora, portate allo stremo, situazioni come quella di Rebibbia si verificano.
Nel carcere romano, i bambini e le loro mamme vivono in quella che è la sezione femminile dell’istituto penitenziario che ai più piccoli riserva delle zone di asilo nido, luoghi assolutamente inidonei alla crescita e all’armonioso sviluppo della persona. Due fattori ignorati ma fondamentali, garantiti anche da quella Carta dei figli dei genitori detenuti approvata in Italia nel 2014, primo caso in Europa. Firmato dall’allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando, dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Vincenzo Spadafora e dalla Presidente dell’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus Lia Sacerdote, il protocollo di intesa – aggiornato nel 2016 con l’obiettivo di una sua europeizzazione – stabiliva ben 8 articoli, ognuno dei quali dedicato alla salvaguardia del diritto/dovere alla genitorialità e, dunque, del rapporto genitore-figlio che non può assolutamente essere messo in pericolo nemmeno in caso di reclusione. In ogni modo, la prole non deve separarsi da chi l’ha generata poiché a quel legame affettivo va assicurata continuità e priorità: migliorando le strutture ospitanti, garantendo le visite settimanali e la privacy che queste necessitano, trovando il giusto equilibrio tra le esigenze di sicurezza e i buoni contatti familiari, fornendo al personale competenze adeguate, dando priorità, laddove possibile, a misure alternative alla custodia cautelare in carcere. Perché i bambini, soprattutto i più piccoli e soprattutto se non hanno nessuno che si occupi di loro, devono restare con la mamma, non solo se questa non può fare altrimenti e non solo fino ai 3 o ai 6 anni. Una separazione, se forzata, arreca enormi danni e disagi a entrambe le parti in causa. È violenza ingiustificata.
I numeri ci dicono che le donne in carcere rappresentano statisticamente una minoranza rispetto agli uomini, sia per ciò che concerne i crimini sia per ciò che concerne la recidiva. Non per questo, però, a esse va dedicata un’attenzione – istituzionale e mediatica – inferiore, talvolta nulla. Non per questo se ne deve parlare solo perché due bambini sono morti, vittime di un’instabilità psicologica evidente. È importante, in cambio, tenere sempre alto l’interesse sulla discrasia tra quanto viene normato e quanto viene effettivamente fatto, e soprattutto su come ciò che viene normato viene concretizzato. Gli istituti penitenziari devono smettere di essere discariche sociali, luoghi dove depositare i nostri fallimenti, i nostri errori, i nostri “scarti”. Un detenuto resta un essere umano, così come una detenuta resta una mamma. E a una mamma, anche se ha sbagliato, va data una pena, va tolta la libertà ma non un figlio. I bambini non sono i genitori, non hanno le loro colpe e non devono pagarle. È tempo che i diritti vengano riconosciuti.
Mariaconsiglia Flavia Fedele