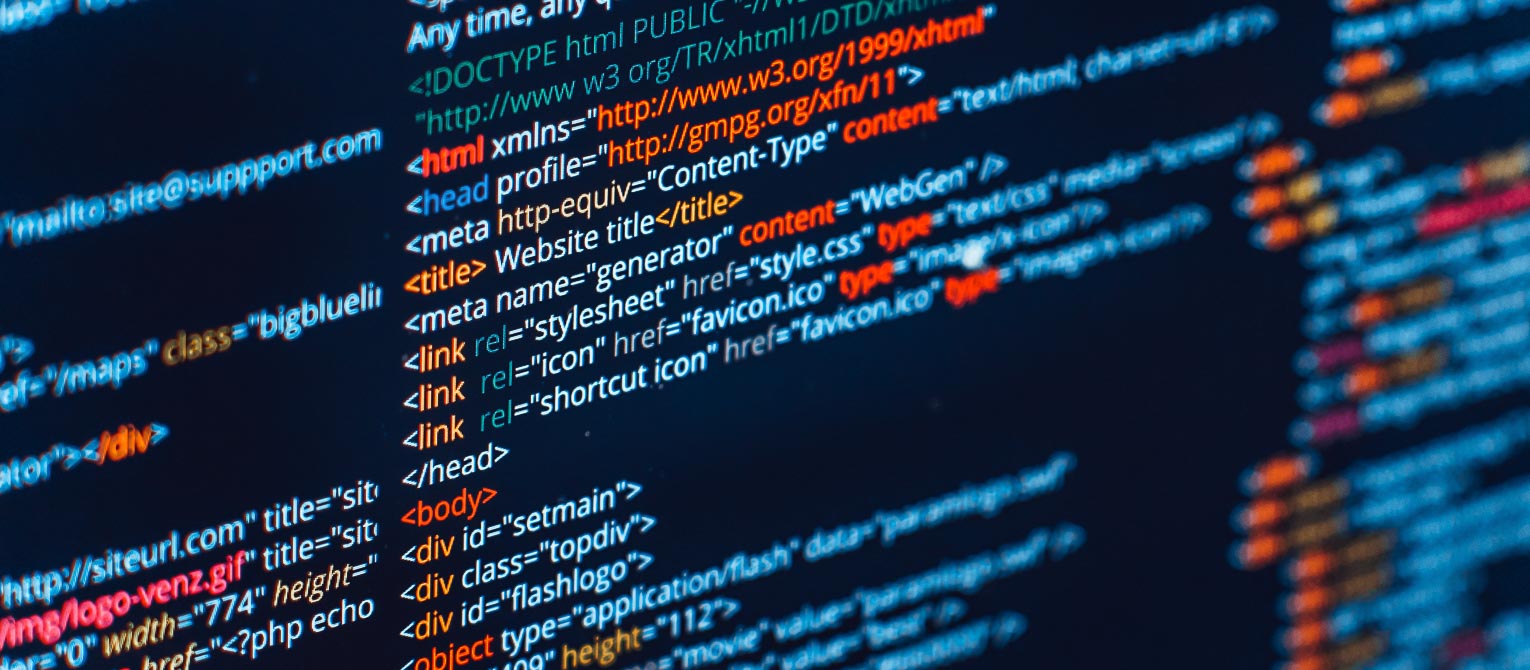Le donne sono state le protagoniste della più grande rivoluzione del Novecento, ma si tratta di una rivoluzione incompiuta, ovvero realizzata solo ‘a metà’, perché ha prodotto straordinari cambiamenti nella vita delle donne, in famiglia, nel lavoro, nella società, senza però avere ancora indotto corrispettivi mutamenti nella vita degli uomini. E sono le donne, e più di tutte le madri, equilibriste in bilico tra l’impegno professionale e le responsabilità familiari, più istruite ma sistematicamente meno pagate degli uomini, minoritarie nei vertici aziendali e nelle più alte cariche istituzionali, a pagare il prezzo di una parità ancora non realizzata. Ma si tratta, anche in questo caso, di una narrazione a metà, appiattita sulla denuncia della discriminazione femminile. E dunque incapace di squarciare il velo sugli svantaggi della condizione degli uomini, e dei padri, gravati da aspettative di comportamento, e di successo, che possono rivelarsi per molti di loro un onere troppo pesante – se non impossibile – da realizzare, o anche semplicemente indesiderato.
Sono tali aspettative a pesare sulle scelte scolastiche dei ragazzi, rendendoli meno liberi delle loro coetanee di assecondare le proprie inclinazioni e preferenze, ed è forse anche per questo che le seconde raggiungono livelli di istruzione più elevati e risultati comparativamente migliori. Un fenomeno, quest’ultimo, che meriterebbe di essere meno celebrato e meglio approfondito, cercandone le cause, che certamente hanno a che vedere con una composizione del corpo insegnante a nettissima maggioranza femminile. Ed è forse la pressione inconsapevole a proiettarsi verso gli sbocchi occupazionali più ‘adatti’ agli uomini a tenere i giovani maschi ai margini di quegli ambiti professionali – dal sistema educativo al lavoro sociale – in cui la loro presenza sarebbe quanto mai preziosa, se non altro per impedire che i padri di domani crescano circondati da figure quasi tutte femminili.
Dentro i luoghi di lavoro, sono soprattutto le mamme a scontare le falle dei sistemi di conciliazione. Quando la conciliazione è un diritto negato, che le impone di restare fuori dal mercato; ma anche quando è definita come problema femminile, ed è scambiata con la rinuncia alla carriera. Ma per questa stessa ragione sono i padri che, in modo speculare, fanno i conti con l’invisibilità della loro condizione di genitore, con culture aziendali e prassi organizzative che li discriminano nella fruizione dei dispositivi per la conciliazione, e con bilanci familiari che rendono più vantaggioso che siano le madri a utilizzare i congedi parentali. Una delle conseguenze, troppo spesso sottovalutate, è quella di privare i bambini del diritto a essere accuditi da entrambi i genitori.
Nell’evenienza di una rottura coniugale, sono le donne – tanto più quanto più si erano identificate con il ruolo di moglie e madre – le prime a pagarne le conseguenze sul piano dell’autonomia economica e della solitudine, ma sono i padri che più spesso si ritrovano a fare la fila nelle mense per i poveri, e ad essere travolti da una spirale involutiva, che dopo la famiglia li porta a perdere anche il lavoro. Perfino le pratiche migratorie rivelano i costi e le ambivalenze dei regimi di genere, riverberandosi sulla concezione della maternità e della paternità. Le madri che migrano separandosi dai figli rappresentano la forma più dolorosa di disuguaglianza globale, ma sconcerta la sostanziale invisibilità della migrazione dei padri. Uno studio promosso dalla Conferenza episcopale filippina rileva, al riguardo, come il problema sia proprio ‘ciò che non fa problema’, interrogandosi sulle conseguenze di un’intera generazione che cresce considerando normale l’assenza del padre.
Ma la denuncia più forte di un regime di genere che impone agli uomini il ruolo di principale breadwinner – colui che porta a casa il pane – ci arriva dalla constatazione che è soprattutto per loro che la perdita del lavoro costituisce un’esperienza particolarmente drammatica, tale da decretare un fallimento tout court esistenziale, oggi come nel passato. Non per caso, sebbene la disoccupazione continui a colpire le donne più degli uomini, sono questi ultimi a rischiare di esserne definitivamente sopraffatti. La crisi ne ha offerto una testimonianza estrema, col susseguirsi di suicidi (pressoché tutti) al maschile. E non per caso sono gli imprenditori del Nord Est i principali protagonisti di questa tragedia, ovvero coloro che meglio hanno interpretato un modello di cittadinanza maschile fondata sul lavoro.
La femminilizzazione della società, sovente evocata, è la retorica che preannuncia, o quanto meno auspica, l’avvento di un nuovo modello di pensare al lavoro e al suo rapporto con la famiglia e la società, fondato sulla primazia di un ‘codice materno’ che instilli nei luoghi della produzione i linguaggi dell’empatia e della sollecitudine, prometta la ricomposizione secondo una logica di condivisione del lavoro retribuito e di quello familiare, conferisca piena cittadinanza sociale al lavoro informale di cura. Altrettanti passaggi indispensabili ad affrancare le donne dalla loro tradizionale condizione di subalternità.
Ma la liberazione delle donne, e delle madri, non potrà realizzarsi se non insieme a quella dei padri, e attraverso una trasformazione delle pratiche e delle culture sociali che consenta, alle une e agli altri, d’indirizzare la propria esistenza e dargli un senso secondo un orizzonte di autentica libertà; di ricomporre i diversi ambiti vitali, superando la concezione dell’esperienza lavorativa e dalla vita personale come domini alternativi e tra loro in conflitto; di rialzarsi nonostante gli insuccessi e i fallimenti a livello professionale e familiare. Partendo però dalla consapevolezza che non di femminilizzazione della società occorre parlare, bensì di una società che riconosca come questi traguardi rispecchiano l’autenticità della natura umana e la sua intrinseca moralità. E che riconosca, accanto al codice materno, l’essenzialità di quello paterno, ovvero di un codice che offra, al contempo, margini di libertà e protezione, ai padri (e alle madri) di oggi e a quelli di domani.
LAURA ZANFRINA,da L’Avvenire